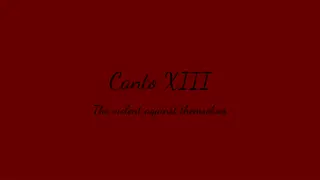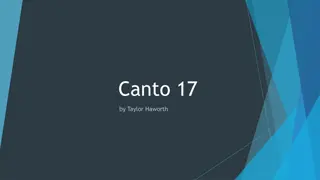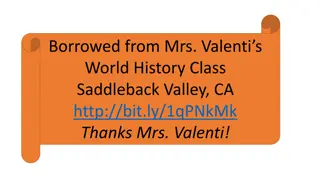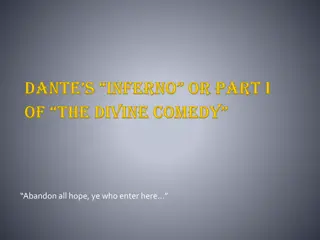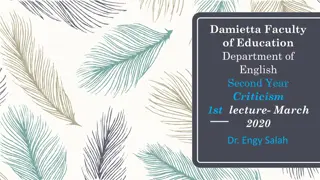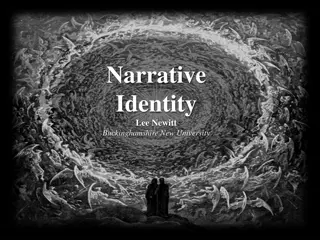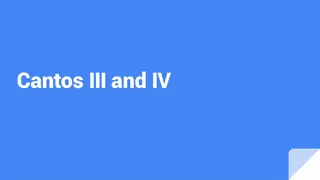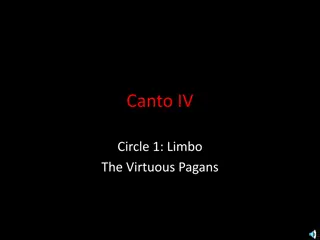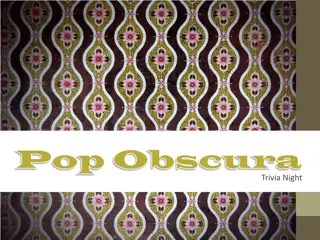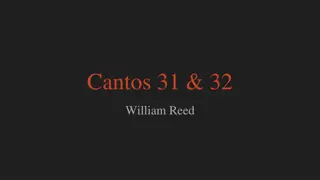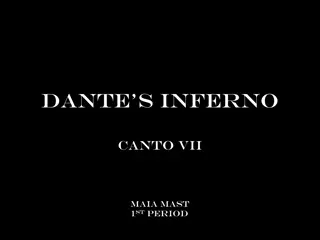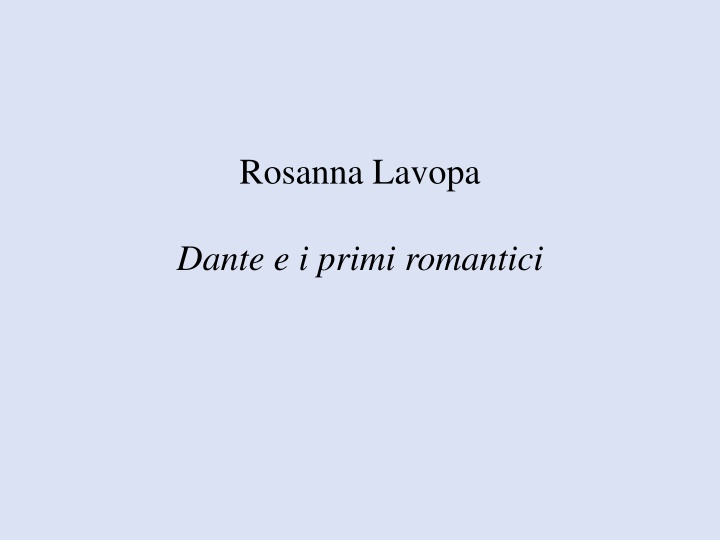
Exploring the Depths of Dante's Commedia and Western Literature Realism
Dive into the rich tapestry of Dante's Commedia and Western literature realism, as seen through the lenses of scholars like Marco Santagata and Erich Auerbach. Discover how the Commedia serves as an encyclopedia of knowledge, blending history, politics, theology, and more. Uncover the nuanced styles of representation in European literature and gain insights into the intricate ways reality is portrayed in these literary masterpieces.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Rosanna Lavopa Dante e i primi romantici
Marco Santagata, Modernit della Commedia, Salerno Letteratura, 2016. Gi a partire dai primi lettori e commentatori della Commedia si generalizzata l idea che questo poema contenga gran parte dello scibile umano (ovviamente del tempo di Dante); in altre parole, che sia una grande enciclopedia dei saperi. L idea non sbagliata. La Commedia anche una grande enciclopedia dei saperi, un enciclopedia estesa dalla fisica alla cosmologia, dall etica alla teologia, dalla storia alla politica. Ma nella Commedia non tutto di impostazione enciclopedica. [ ] Una enciclopedia ha il compito di informare e insegnare [ ].
Modernit della Commedia, Marco Letteratura, 2016. Santagata, Salerno Se per molte sue parti si pu dire che la Commedia un enciclopedia, per altre si deve rovesciare l affermazione: in zone non secondarie del suo racconto la Commedia il primo libro a richiedere per la piena e totale comprensione l aiuto di una grande enciclopedia. Questo aiuto indispensabile perch il testo, spesso, non autosufficiente: quasi a ogni verso necessita di essere integrato da nozioni e conoscenze che esso non fornisce. propria [questa tecnica narrativa], pur con qualche eccezione, di quelle parti testuali nelle quali essa parla di fatti storici e cronachistici che coinvolgono in modo particolare il personaggio Dante. [ ] Emerge, allora, una apparente contraddizione: ci che immaginario concreto e realistico, ci che storico ridotto a pochi segni, affidato all allusivit .
Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Einaudi, 2000. Nel primo capitolo, La cicatrice di Ulisse, individua e analizza due tipi stilistici fondamentali attraverso cui la letteratura europea ha rappresentato la realt : Omerico Biblico - descrizione particolareggiata; - rilievo dato ad alcune parti; - luce uguale; - oscuramento di altre parti; - collegamenti senza lacune; - stile rotto; - espressione franca; - suggestione del non detto; - primi piani; - sfondi molteplici (interpretazione); - evidenza; - rappresentazione divenire storico; - limitazione sviluppo storico; - approfondimento problematico. - limitazione problematica umana. Rappresentazione dall esterno della realt / Rappresentazione dall interno della realt Ritrae la realt nella sua compiutezza / Fa percepire la realt a sprazzi, con illuminazioni improvvise e ampie zone d ombra (Secondo Marco Santagata lo stile che pi si avvicina alla Commedia)
Marco Santagata, Modernit della Commedia, Salerno Letteratura, 2016. Ebbene, penso che sia proprio il modo ellittico, lacunoso e scorciato di rappresentare la realt a renderla a noi vicina, a farne un testo che ancora ci attrare e fa scattare la nostra identificazione. Pi vicina a noi di quanto lo sia stata ai lettori dei secoli passati. La vicinanza prodotta da una comune sensibilit stilistica. Il fatto che i testi letterari (ma il discorso potrebbe essere allargato a quasi tutte le attivit artistiche della nostra epoca) non siano autosufficienti ma richiedano di essere integrati da ci che sta fuori di loro, in effetti, un carattere tipico della letteratura moderna.
Erich Auerbach, Studi su Dante (1929), traduzione di M.L. De Pieri Bonino e D. Della Terza, Milano, Feltrinelli, 1963. Individua nell et romantica il punto cruciale, di svolta, della storia della ricezione dantesca, il momento critico in cui la Divina commedia viene riscoperta. - Nel Settecento a predominare era la visione di Dante data dal Voltaire, che definiva la Commedia bizzarra , densa di assurde e barbariche invenzioni (Voltaire, Dante, in Id., Oeuvres de Voltaire, dir. M. Beuchot, Tome XXVIII. Dictionnaire philosophique, Tome III, Paris, Lef vre, 1829, pp. 288-293). - Con l affermazione della dottrina romantica, invece, gli argomenti usati per celebrare Dante erano pressoch gli stessi di quelli usati dagli illuministi per condannarlo. Se fino a questo momento era valso come rimprovero il fatto di essere definito come poeta barbarico, un poeta appartenente ad un periodo arcaico del suo popolo, ora questo stesso fatto si trasformava in un vanto; e se finora i tratti troppo forti e l eccesso espressivo erano stati giudicati come privi di gusto e bizzarri, adesso il gusto viene disprezzato e ci che bizzarro viene esaltato (p. 172). [Si assiste a un radicale rovesciamento dei valori]. - Al contempo, per , sottolinea lo stesso Auerbach, la storiografia critica romantica non ha intrapreso, contro ogni ragionevole attesa, uno studio esaustivo sul nostro poeta.
Friedrich Schlegel, ber das Studium der Griechischen Poesie (1797); trad. it. Sullo studio della poesia greca, a cura di A. Lavagetto, con un saggio di G. Baioni, Napoli, Guida, 1988, p. 120. Solo nella cultura naturale, dove tutte le componenti dell arte e del gusto si sviluppano, si perfezionano e giungono a compimento in piena armonia, il bello supremo pu farsi realt . Nella cultura artificiale, dove l intelletto (che ne il principio di governo) opera separazioni e commistioni innaturali, quella armonia va irrimediabilmente perduta.
Friedrich Schlegel, ber das Studium der Griechischen Poesie (1797); trad. it. Sullo studio della poesia greca, a cura di A. Lavagetto, con un saggio di G. Baioni, Napoli, Guida, 1988, pp. 104-105. La rivoluzione estetica stabilisce due requisiti come condizioni preliminari necessarie alla sua riuscita. Il primo l energia estetica. Il genio dell artista,l originalit della rappresentazione ideale e della potenza estetica non si possono n acquisire n compensare con altre doti [ ]. Ma anche la predisposizione pi felice non sufficiente a fare il grande artista, perch senza il vigore e l ampiezza delle facolt morali [ ] nessuno riesce a penetrare nel cuore pi sacro del tempio delle muse. Di conseguenza il secondo requisito necessario per il singolo artista [ ] la moralit .
Friedrich Schelgel, Dialogo sulla poesia (Athenaeum, 1800), in Id., Frammenti critici e scritti di estetica, Introduzione e traduzione di V. Santoli, Firenze, Sansoni, 1967, p. 176. [ ] il gran Dante, il sacro fondatore e padre della poesia moderna. [ ] in un solo punto concentr la forza del suo spirito inventivo, e in un grandioso poema racchiuse con braccio potente la sua nazione e il suo tempo, la Chiesa e l Impero, la sapienza umana e la rivelazione, la natura e il regno di dio. Una scelta di ci che di pi nobile e di pi turpe egli aveva veduto, di ci che di pi grande e di pi raro poteva immaginare; la pi schietta rappresentazione di s e dei suoi amici, la pi splendida glorificazione dell amata; fedelissimo e verissimo nella sfera del visibile e tuttavia pieno di una segreta significazione e relazione con l invisibile. Commedia = poesia e filosofia
Circolo di Coppet (A.L. Sta l-Holstein, J.Ch.L. Simonde de Sismondi, A.W. Schelgel) Distinzione cronologica antico moderno cultura pagana cultura cristiana religione sensuale religione trascendentale (beni esteriori e temporali) (desiderio, infinito) felicit cui non si pu conseguire in questo mondo
A.W. Schlegel: Lezioni berlinesi (1802-1803) - Commedia = rappresentazione allegorica cristiana dell universo Dante = primo grande artista romantico Esempio Struttura delle terzine e simmetria delle tre cantiche: - NO un gioco di gusto gotico ; - S espressione di spiritualit cristiana. Il numero, infatti, il simbolo del tempo e il tempo non altro che tensione ideale verso l infinito.
A.W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, tr. di G. Gherardini, nuova edizione a cura di M. Puppo, Genova, il Melangolo, 1977, p. 11. Li eruditi, che soprattutto avevano occupato i tesori dell Antichit , inetti a segnalarsi da s con produzioni originali, attribuirono agli antichi una autorit illimitata. [ ] Ma l ammirazione pi giusta nella sua causa divent funesta ne suoi effetti, allorch si arriv fino a sostenere non v esser nulla a sperare per lo spirito umano fuor del sentiero della imitazione, e quindi si rifiut tutto quanto s allontanavada modelli classici, come effetto d una barbara degenerazione, e prova d un gusto depravato. Fortunatamente cos non sentirono i grandi artisti e i grandi poeti che hanno illustrato i secoli moderni. Per vivo che fosse l entusiasmo che inspiravano loro gli antichi, e per grande che pur fosse il loro secreto desiderio d eguagliarli, l originalit , essenziale al loro ingegno, li forz ad aprirsi una strada particolare, e ad improntar nelle proprie produzioni il loro individuale sigillo. Tal fu l esempio che diede l Allighieri, restauratore della moderna poesia in Italia: mentr egli si chiamava discepolo di Virgilio, mand fuori un opera che per nessun conto all Eneide si rassomiglia, e nella quale, per rispetto almeno alla forza, alla verit , all estensione e alla profondit delle idee, egli sorpassa, al mio parere, di lungo tratto colui che al dire di esso fu suo maestro.
J.Ch.L. Simonde de Sismondi, De la littrature du midi de lEurope (1813), Paris, chez Treuttel et Wurtz, 1813, t. I, p. 386. - Libera Dante dall ossequio a regole troppo vincolanti ( la poesia di Dante era fuori dalle antiche regole dell'arte poetica, non apparteneva propriamente a nessun genere, e Dante poteva essere giudicato solo dalle leggi che si era dato ), ma comunque non da quelle invariate dell arte ( Si conformava alle regole essenziali dell'arte, a quelle invariabili: l'unit di intenti, l'unit di progresso, l'impronta di un potente genio che vede simultaneamente il tutto e le sue parti, che dispone con facilit di masse pi grandi e che abbastanza forte da osservare la simmetria senza mai provare disagio ). - Accentua romanticamente la ricerca degli elementi nuovi, come il popolaresco nazionale e l umano ( il soggetto era nel secolo [di Dante] il pi popolaresco di tutti, e a un tempo il pi profondamente religioso, il pi strettamente collegato alle rimembranze di patria, di gloria, di fazione ).
J.Ch.L. Simonde de Sismondi, De la littrature du midi de lEurope (1813), Paris, chez Treuttel et Wurtz, 1813, t. I, p. 350. L analisi della Commedia contenuta nell opera sismondiana fu tradotta e riassunta da Giovanni Berchet nel Conciliatore (7 gennaio 1819, n. 37). Nessun poeta aveva ancora fortemente agitato le anime, nessun filosofo era penetrato nelle profondit del pensiero e del sentimento, quando apparve il pi grande degli Italiani, il padre della loro poesia, Dante, che mostr come un potente genio potesse disporre di nuovo di questi materiali grossolani, in modo da costruire un edificio imponente come l universo di cui era l immagine. Invece di canzoni d amore, indirizzate a un amante immaginaria, invece di madrigali freddamente spirituali, sonetti dolorosamente armonici, allegorie false o forzate, gli unici modelli erano quelli che Dante aveva davanti agli occhi e concep in un linguaggio moderno tutto il mondo invisibile .
A.L. Stal-Holstein, Corinne ou lItalie (1807), d. C. Hermann, Paris, Editions des Femmes, 1979, t. I, p. 53, Livre II: Corinne au Capitole, chapitre 3. Dante, l Omero dei tempi moderni, poeta sacro dei nostri misteri religiosi, eroe del pensiero, ha immerso il suo genio nello Stige, per approdare all Inferno, e la sua anima era profonda come gli abissi che descriveva. L Italia, al tempo del suo potere, rivive in Dante. Animato dallo spirito delle repubbliche, guerriero oltre che poeta, ha domato la fiamma delle azioni tra i morti, e le sue ombre hanno una vita pi forte dei vivi di oggi. I ricordi della terra li inseguono ancora; le loro passioni senza meta si scontrano nei loro cuori; sono agitati dal passato, che sembra loro ancor meno irrevocabile del loro futuro eterno. Si direbbe che Dante, bandito dal suo paese, abbia trasportato le pene che lo divoravano in regioni immaginarie. Le sue ombre chiedono costantemente notizie dell'esistenza, come lo stesso poeta indaga sulla sua patria, e l'inferno gli si presenta nei colori dell esilio.
A.L. Stal-Holstein, Corinne ou lItalie: Il passo dell opera relativo a Dante sar non a caso citato da Ludovico di Breme, nel suo Manifesto romantico del 1816, Intorno all ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani, insistendo in particolare sull immagine dell esule: Il Dante sperava dal suo poema ottenere la fine dell esilio; mediatrice ne invocava la fama, ma ei mor anzich raccogliere la palma della patria (cfr. Discussioni e polemiche classico-romantiche, a cura di E. Bellorini, reprint a cura di A.M. Mutterle, Bari, Laterza, 1975, vol. I, p. 51).
A.L. Stal-Holstein, Sulla maniera e lutilit delle traduzioni, in Biblioteca Italiana , a. I, gennaio 1816; poi in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., pp 3-9. - commercio de pensieri / eruditi italiani che vanno continuamente razzolando le antiche ceneri . A.L. Sta l-Holstein, Risposta alle critiche mossele, in Biblioteca Italiana , a. I, giugno 1816; poi in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., pp. 64-67. - Gli scienziati de quali l Italia ha tanta ragion d invanire, cio Volta, Scarpa, Piazzi, Oriani, ecc., si istruiscono con diligenza dei progressi e delle scoperte che gli stranieri fanno nelle scienze; ma il sacro orrore d ogni nuova idea di cui si vuol fare una religione in letteratura, tende a spegnere interamente questo ramo dello spirito umano. [ ] Dante aveva una erudizione immensa per l epoca in cui visse, e si pu asserire che se un uomo del suo genio ricomparisse nel mondo non trascurerebbe ogni studio che valesse a procacciargli una idea di pi .
Ludovico di Breme, Intorno allingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani (1 giugno 1816); ora in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., pp. 25- 56. I. Ad epigrafe dello scritto l autore contegno di arroganza nazionalistica assunto dai denigratori della Sta l l apostrofe di Dante ai superbi del Canto XII del Purgatorio (vv. 70-72): oppone contro il Or superbite, e via col viso altiero ITALE GENTI! e non chinate l volto, figliuoli d Eva S che veggiate l vostro mal sentiero!
Ludovico di Breme, Intorno allingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani (1 giugno 1816); ora in Discussioni e polemiche classico- romantiche, cit., pp. 25-56. II. Come atto di accusa nei confronti della matrice retorico-umanistica, egli opera una netta distinzione tra una letteratura di idee e di sentimenti e una letteratura di parole e di grammatiche, tra una lingua poetica e creativa e una lingua pedante, scevra di contenuti. E lo fa ponendo in primis Dantenell elenco di quegli scrittori che si sono posti al servizio delle idee e della verit (e non delle poetiche o del potere): Noi, torno a dire, non figli dei Crisolora, n di Gemisto Pletone, n di Giorgio da Trebisonda, n del cardinal Bessarione e n tampoco figli dell Aurispa o del Filelfo o di Marsilio Ficino, del Trissino, del Bibbiena, del Castelvestro, ecc., ma dell Alighieri, per Dio! dell unico, incomparabile, eterno Alighieri .
Ludovico di Breme, Intorno allingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani (1 giugno 1816); ora in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., pp. 25-56. III. Invita a riflettere sulla dottrina classica dell imitazione. I classicisti pretendono che i moderni debbano copiare i Greci e i Latini, poich solo questi sono riusciti ad imitare fedelmente la natura. Principio primo della letteratura, tuttavia, non imitare la natura, bens studiare l uomo, l infinita interiorit di ogni individuo. La vera poesia nasce da una forza latente, da uno spirito ascoso , che ci rende idonei a precepire ed esprimere la gran vita della natura, nella quale vi prima di ogni cosa il soggetto inserito nella sua civilt , nella sua storia. La natura ci ha reso suoi rivali, suoi interpreti, per cui dovremmo gareggiare con lei nell invenzione, piuttosto che riprodurre fedelmente quel che ci circonda: bisogna scrivere secondo la propria immaginazione, essere figlio e protagonista del proprio tempo. Romantico ante litteram = Dante (dilatazione del romanticismo a categoria extrastorica) [ ] il sommo italiano [ ] collo scarso sussidio di una lingua ancora fanciulla sollevato aveva il suo Ugolino a paro del Laocoonte virgiliano .
Ludovico di Breme, Il Giaurro. Frammento di novella turca scritto da Lord Byron (1818); ora in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., pp. 254-313. Il valore del poeta si manifesta nel saper cogliere il concetto ideale del modello, mediante l impiego di forme diverse (originalit ) e convenienti ai tempi (letteratura impegnata). Dante riprodusse il dramma familiare del Laocoonte virgiliano, adattandolo alle consuetudini, alle situazioni, allo spirito del proprio tempo. Invaso dalla favola virgiliana del Laocoonte, Dante, onde ripeterne degnamente gli effetti, non ritenne di essa che la pura drammatica situazione, il cui nerbo tutto riposto nella reciproca dolorosissima ripercussione degli affetti paterni e filiali. A riprodurre pertanto un simile quadro, s avvide egli, quel miracoloso ingegno, ch era d uopo raccomandar quella situazione a costumi, avvenimenti ed accessori tutti analoghi ai suoi paesi ed a suoi giorni. Non fu egli, no, di cos corta veduta da confondere l ideale d una favola colle forme, onde incarnarla nelle immaginazioni e negli affetti; perch a lui non fuggiva che, se la maest creatrice del poeta si manifesta nel ritrovamento del concetto ideale, la bravura dell artefice poetico consiste nell attingerne le forme dall indole onde sono consumate e atteggiate le fantasie (pp. 275-276).
Silvio Pellico, Lettere milanesi (1815-1821), a cura di M. Scotti, Torino, Loescher, 1963, p. 30. Gi Silvio Pellico, nel dicembre del 1815, aveva comunicato le stesse idee al fratello Luigi, ricorrendo, al fine di far luce sulla necessaria diversit tra modernit e antichit , alla grandezza inventiva dell affresco dantesco: Dante, che da filosofo imitava Virgilio e non da pedante, cap che riproducendo un Laocoonte farebbe assai meno terrore e piet [nella modernit ], che non avea fatto agli antichi quel di Virgilio agli antichi che ancor credevano o si ricordavano d aver creduto ai miracoli degli Dei. Che fece Dante? L Ugolino tradito dall arcivescovo Ruggieri, e morto di fame in una torre. Non si fa guerra ai classici; si ammira il Laocoonte; ma l Ugolino pi dei nostri tempi .
Silvio Pellico, rec. Childe Harolds Piligrimage. Di Lord Byron. Canto IV (3 gennaio 1819), inIl Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, a cura di V. Branca, Firenze, Le Monnier, 1948-1954, vol. II, pp. 3-6. Pellico, il pi foscoliano tra i romantici e a quel tempo in contatto epistolare col Foscolo, nel menzionare il tempio di Santa Croce, tiene a precisare: dove riposano i quattro grandi che Foscolo gi celebr con s sublime poesia . Non a caso, subito dopo, ricorda con evidenti riprese dei Sepolcri, la sepoltura di Dante lontano dalla patria: Ma dove giacciono i tre Toscani [ ], dove posarono le loro ossa, distinte dalla nostra creta comune in morte come in vita? Si sono esse ridotte in polvere senza che i marmi della loro patria nulla avessero a dire? Non vi furono cave che potessero fornir marmo da innalzar loro un busto? Non affidarono essi la filiale loro terra alla patria? Ingrata Firenze! Dante dorme lungi, come Scipione, sepolto dal rimproverante lido. Le tue fazioni nelle loro guerre civili proscrissero il poeta, di cui il nome per sempre adoreranno con inutili rimorsi i figli de tuoi figli .
Foscolo (polemica classico-romantica: questione oziosa, an idle enquiry Essay on the present literature of Italy) Negli scritti foscoliani, il nome di Dante compare: - 1795: ode A Dante; - 1803: Commento a La Chioma di Berenice. Dante aveva cantato i tumulti d Italia sul tramontare della barbarie, valoroso guerriero , ardente cittadino ed esule venerando (anche se la religione di Dante s inviluppa in tenebre e in sofismi , rispetto alla religione greca, la quale accoglie tutte le passioni e le azioni ); - 1806-1807: Dei Sepolcri (vv. 173-174). E tu prima, Firenze, udivi il carme che allegr l ira al ghibellin fuggiasco. Esprime spirito giacobino e democratico. La scrittura dantesca un utile ammaestramento per gli Italiani del presente. - 1816: Lettera del 12 marzo, scritta da Hottingen a Quirina Mocenni. Spesso io ripensando a guai di quel grand uomo, e alla magnanimit con che li convert a invigorirsi il cuore ed esercitare l ingegno, io mi sollevai dall abbattimento in cui le disgrazie mie volevano pure prostrarmi: dunque bene che io imiti il suo sdegno generoso .
Foscolo Giuseppe Mazzini, Moto letterario in Italia (1837), in Id., Scritti editi ed inediti, E.N., 1906-1943, vol. VIII (1910), p. 352. Infiniti volumi s erano, prima di lui [Foscolo], scritti su Dante, da grammatici, filologi, antiquari o estetici: ma Foscolo prima studi in lui il patriota e il riformatore. Non riusc fin dove avrebbe potuto [ ] pur nondimeno ei riconobbe in Dante pi che il poeta o il creatore della Lingua, il grande cittadino, il pensatore profondo, il Vate religioso, il profeta della nazionalit , dell Italia. Dove altri s era fatto spiluccatore, tormentatore di sillabe, ei cerc idee; dov altri avea chiamato gli Italiani ad ammirare immagini di poesia, ei s addentr nel sentimento che le avea suggerite. Guid la Critica sulle vie della Storia .
Foscolo - 1818 (febbraio e settembre): due articoli pubblicati sull Edinburgh Review . I. Intende spiegare Dante alla luce della cultura, delle passioni e delle vicende dei suoi tempi. Quadro storico: et di mezzo fra civilt e barbarie, lacerata da profonde passioni, mistica e violenta. II. Sottolinea la situazione di oscurit della secolare esegesi dantesca. Il poema di Dante come un immensa foresta, che desta venerazione per la sua antichit e stupore per la mole degli alberi, che sembrano avere raggiunto la loro gigantesca statura d un tratto, per la forza della natura aiutata da un arte misteriosa. una foresta affascinante per la vastit , ma spaventosa per la sua oscurit e i suoi intrichi. I primi viandanti che tentarono di attraversarla hanno dovuto aprirsi una strada. I successivi l hanno allargata e illuminata: ma la strada resta la stessa e la maggior parte di questa foresta ancora, dopo le fatiche di cinque secoli, avvolta nella sua primitiva oscurit . - I. 1823: A parallel between Dante and Petrarch. Non si tratta di un confronto volto a stabilire un criterio di gerarchizzazione o superiorit , ma di una stringente caratterizzazione di due opposti mondi umani e letterari. Petrarca ci avviluppa in oziosa malinconia, nelle pi molli e dolci visioni ; Dante, come tutti i poeti primitivi, lo storico dei costumi del suo secolo, il profeta della sua patria e il pittore dell uman genere . II.
Foscolo, Principj di critica poetica (1824), in Id., Saggi di letteratura italiana, E.N., vol. XI, Firenze, Le Monnier, 1958,p. 172. Nel ridefinire il rapporto arte-natura, avvalora l ipotesi secondo cui la funzione mimetico-produttiva si qualifica non per l esattezza della copia , ma per l illusione evocativa che il poeta riesce a prospettare. Il genio dotato di forza del sentire va oltre la natura stessa, la corregge, offrendo dell appercezionedell esistente una visione compensativa e pi confacente alle attese dell individuo. Quando Dante fa raccontare al conte Ugolino com ei, destandosi e udendo i suoi figliuoli dimandar del pane, si morse per dolore le mani, non fece che rappresentare la natura reale; ma quando tutti i quattro suoi figliuoli, credendo ch egli volesse mangiare le sue proprie mani per fame, si alzano tutti e quattro ad un tempo, e gli fanno ad una voce l offerta: Padre, assai ci fia men doglia Se tu mangi di noi, tu ne vestisti Queste misere carni e tu le spoglia, questa non natura reale; natura esaltata spinta quanto pu andare, e che riesce terribile appunto perch nessuno potea prevedere la disperata offerta di quegli innocenti . I. Descrittivismo naturalistico; II. Capacit ideativa e realizzatrice del genio.
Pietro Borsieri, Avventure letterarie di un giorno o consigli di un galantuomo a vari scrittori (settembre 1816);ora in Discussioni e polemiche classico- romantiche, cit., pp. 85-178. I. Col chiaro intento di avvicinarsi alle posizioni teoriche del di Breme, Borsieri apre il proprio pamphlet con una epigrafe che ricalca i versi danteschi (vv. 47-48) dell Inferno, XXIV: Seggendo in piuma In fama non si vien n sotto coltre. II. Dedica un intero capitolo, il secondo, alla censura della Biblioteca Italiana, rivendicando la necessit di articoli e disquisizioni non puramente grammaticali , bens filosofici e letterari dei grandi poemi di Dante, Ariosto e Tasso: tra le poche eccezioni alla spaventosa vacuit del giornale, l articolo di Vincenzo Monti, Un passo di Dante mal inteso da tutti gli espositori: Io non sosterr che tutta la parte letteraria della Biblioteca sia distesa con una s spaventosa vanit . V qua e l qualche eccezione [ ], le Illustrazioni di un passo di Dante [ ]. Si fa una sposizione di Dante con quel corredo d idee senza il quale non dovrebbe omai esser permesso di esporre interpretazioni e dispute grammaticali .
Vincenzo Monti, Epistolario, a cura di A. Bertoldi, Firenze, Le Monnier, 1929, vol. IV, pp. 242-243. Il 1 settembre del 1815, all invito che Giuseppe Acerbi gli aveva rivolto di scrivere la Prefazione alla Biblioteca Italiana , Monti rispose: Una prefazione al giornale, portante un cenno storico-critico sullo stato dell italiana letteratura al cominciare di questo secolo, parmi bel pensiero, e volentieri io mi adoprer di porlo ad effetto. Ma due ostacoli mi disturbano: l uno la parte scientifica, intorno alla quale d uopo che altri mi somministri i debiti materiali. L altra risguarda le belle lettere, e nella riforma in queste avvenuta, pretendendo io d aver non poco contribuito, col ritornare in onore lo studio dei nostri classici, massimamente di Dante, esiliato dalle scuole per le Lettere virgiliane del Bettinelli, e richiamatovi dalla Bassvilliana e Mascheroniana, mi trovo in angustia non piccola nel toccare questo gran punto. Perciocch n a me lecito il parlare di me medesimo, n giusto il tacere una lode che dal consenso pubblico mi conceduta e a cui sento di avere tutto il diritto . Il futuro per Monti risiedeva nel passato: una riforma letteraria nel presente si pu attuare solo sulla base del modello dantesco (e omerico).
Riforma di Vincenzo Monti Bassvilliana (1793) - Poemetto in terzine volto a denunciare la violenza rivoluzionaria; - Il protagonista un diplomatico francese, Nicolas-Jean Hugou de Bassville, assassinato a Roma, il cui spirito pentito assiste, accompagnato da un angelo, alla rovina della Francia a causa della Rivoluzione, fino all esecuzione di Luigi XVI e all invocato sorgere della coalizione antifrancese. Mascheroniana (1800-1802) - Opera in cinque canti in terzine sulla falsariga della Bassvilliana, rimasta incompleta e scritta in occasione della morte dell'amico scrittore, sacerdote e naturalista illuminista Lorenzo Mascheroni (1800); - Il protagonista, alla sua morte, sale nel Regno dei Cieli, dove incontra alcuni poeti (Parini, Pietro Verri e Cesare Beccaria): critica nei confronti del trionfo demagogico del potere cui si assiste a Milano. U. Foscolo, rec. a Il Bardo della Selva Nera, in Id., Scritti letterari e politici dal 1796 al 1808, a cura di G. Gambarin, vol. VI, Firenze, Le Monnier, 1972, pp. 467-468. con la Bassvilliana e co canti in morte del Mascheroni diede a divedere [ ] ch egli [Monti] voleva sciogliere questo problema: Pu egli darsi poema narrativo delle cose avvenute ai tempi dell autore?[ ] Unico poeta che narrasse ex professo cose avvenute a suoi giorni fu Dante; poich i Greci e i Latini, lasciando a massimi ed antichi fatti il diritto dell epopea, cantarono i solenni avvenimenti contemporanei con gl inni della poesia lirica, magnificando i fatti pi con le acclamazioni e con lo splendore del verso che col racconto. Sent l autore del Bardo queste ragioni, e dopo avere ne due citati poemetti calcate nobilmente le orme di Dante, e rischiarato con l imitazione il genio di quel sommo poeta, Vincenzo Monti s apre nuovo sentiero e tutto suo per isciogliere il suo problema collegando l epopea alla lirica .
Vincenzo Monti, nel corso delle sue lezioni tenute presso lUniversit di Pavia (1802-1803), riserver attenzione a Dante: I. Un rilancio dantesco investito di una forte ostilit per la poesia arcadica, disimpegnata e formalistica, e segnato dalla richiesta di una poesia delle forti passioni, nata dal genio: la Commedia il pi valido antidoto contro la presente corruzione del gusto , dovuta al dominio di una letteratura di nude parole [polemica nei confronti di un interpretazione arcadica e tipicamente settecentesca della poesia dantesca, rappresentata massimamente dalle Lettere virgiliane di Saverio Bettinelli, il quale aveva criticato della mostruosa Commedia la lingua rozza e stravagante , la costruzione gotica , dovuta a una struttura non regolare , ma soprattutto la commistione di poesia, teologia e scienza, che rendeva l opera stessa propria dell et medievale e dunque del tutto inattuale]. II. La Commedia attuale; lo strumento per riformare la letteratura contemporanea contro la presente corruttela di gusto . III. La Commedia interamente politica e morale, pratica: non ascetica, ma mondana e secolare, in cui l oltretomba paradossalmente insegna non il bene morire ma il bene vivere (G. Contini): Cacciato in esiglio da una patria sostenuta da suoi consigli, onorata dal suo ingegno, e non degna di possederlo, privo d ogni suo avere confiscatogli dal furore de nemici, avvolto nella maest delle sue disavventure, e vagabondo di paese in paese come un profugo scellerato, tutto avendo perduto, fuorch il grand animo, ma straziato dallo sdegno contro i perfidi ed ingrati concittadini, concepisce Dante il disegno di vendicarsi altamente de suoi nemici, per punirli di avergli tolta una patria. N basta ancora. L epocade suoi tempi, per le intestine discordie che laceravano l Italia tutta era fatalmente feconda di delitti politici e religiosi. [ ] Irritato egli dunque contro tutti, deliber di coprirli tutti d infamia [ ]. Dante voleva far la satira de suoi tempi (V. Monti, Lezioni di eloquenza, Bologna, CLUEB, 2002, pp. 218-222).
Vincenzo Monti, Interpretazione di un passo di Dante mal inteso da tutti gli espositori, in Biblioteca Italiana , a. I, t. I, febbraio 1816, pp. 145-154. Interpreta una terzina del canto degli ignavi (Inferno, III, vv. 40-42): Caccianli i Ciel per non esser men belli, N lo profondo Inferno li riceve, Ch alcuna gloria i rei avrebber d elli. maniera francese (nessuna) Gli scacci il Cielo [gli Angeliinoperosi ] per non perdere fiore di sua bellezza ritenendo nel suo seno quei vili. Non li riceve e li scaccia pure l Inferno, perch niuna gloria ne verrebbe ai dannati dall averli in loro compagnia . Ma il pensiero di Dante, di ben altro momento che le parole, merita al fine di essere vendicato in tutta la luce di cui degno: e noi nel piacere di scoprirlo troveremo il compenso alla noia d investigarlo e un eccellente lezione morale all inerzia dei nostri tempi . [ ] la qualit del concetto sia quella che, secondo le regole della sua critica, determini il senso della parola .
Vincenzo Monti, Interpretazione di un passo di Dante mal inteso da tutti gli espositori, in Biblioteca Italiana , a. I, t. I, febbraio 1816, pp. 145-154. Osserva Tacito che ne giorni della tirannide, allorch tutte le faville di libert sono spente, tanta la depressione dei sentimenti e la moral corruttela, che la inerzia s acquista il nome di sapienza. Ma ben torto procederebbe il nostro giudizio se dal sonno della virt romana sotto Nerone estimassimo la virt fiorentina a tempi di Dante; ne quali essendo infiammati gli animi tutti, e tutti eccitati da un efficace e perpetua attivit , l infingardaggine e l indifferenza ne mali pubblici non solo era vizio, ma colpa a tutti gli operosi odiosissima. Dante adunque volea e dovea, siccome cuore ardentissimo, vendicarsi di questi pigri a cuore di gelo. [ ] E dapprima a castigo della pigrizia, a cui tanto si piacquero a questo mondo, li condanna nell altro a correre eternamente dietro a un insegna che mai non si ferma. I miseri son tutti nudi e incessantemente stimolati e divorati, come carogne, da mosconi e da vespe, per le cui acutissime trafitture mandano le orribili grida che udimmo di sopra, e grondano tutti di sangue e di lagrime, raccolte da schifosi vermi a loro piedi. [ ] Li chiama sciaurati che mai non fur vivi [ ]. Dice che sono odiosi, non solo a Dio (nota bene questa espressione), ma odiosi agli stessi nemici di Dio, che quanto dire, agli stessi demonii, agli stessi perduti. A Dio spiacenti ed ai nemici sui. Or dopo averli per questa guisa sommersi nell ignominia, [ ] sar egli credibile che il nostro fiero poeta, dimentico de suoi detti, prorompa in una sentenza tutta contraria, e ne dica (come gl interpreti gli fan dire) che la costor compagnia tornerebbe a gloria dei dannati all Inferno, se vi fossero ricevuti?
Pietro Borsieri, Avventure letterarie di un giorno o consigli di un galantuomo a vari scrittori (settembre 1816);ora in Discussioni e polemiche classico- romantiche, cit., pp. 85-178. Nel capitolo VI, Borsieri sceglie proprio Monti come personaggio centrale: il galantuomo incontra Monti presso i bastioni di Porta Orientale e si incammina insieme a lui verso Piazza della Scala; durante la passeggiata, ha modo di ascoltare l elogio della fantasia poetica di Dante pronunciato dal Monti fittizio : Chi ebbe mai pi genio di Dante? Eppure egli studi per sino i trovatori provenzali, e deriv molte bellezze dalla loro poesia, e cit con riverenza i nomi di alcuni di loro nel suo divino poema. [ ] Or dimando se Dante vivesse ai nostri d , trascurerebbe di imitare Shakespeare, Schiller, Calderone, [egli] che non disprezz i trovatori e i romanzieri? I. II. Dante volle ispirarsi ai precursori stranieri; Se Dante vivesse nei tempi moderni, non trascurerebbe di conoscere gli scritti stranieri (in evidente sintonia con la tesi della Sta l). Principio di universalit della letteratura
Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo (dicembre 1816), in Manifesti romantici e altri scritti della polemica classico-romantica, a cura di C. Calcaterra, Torino, Utet, 1979, pp. 423-486. I. Omero, Shakespear, il Calderon, il Racine, lo Schiller per me sono italiani di patria quanto Dante, l Ariosto, e l Alfieri. La repubblica delle lettere non che una, e i poeti ne sono concittadini tutti indistintamente (p. 433). II. Celebra l affrancamento di Dante dalle regole, nella convinzione che i poeti debbano ritenersi estranei a qualsiasi precettistica: non necessario aggiungere una legge romantica a quelle gi esistenti. Sono forse le Poetiche che dissero come tener la penna in mano a Dante, all Ariosto, a Shakespeare? Al diavolo queste corbellerie! Mostratemi una Poetica anteriore alla esistenza di un poeta. Mostratemi un vero poeta educato e formato dalle Poetiche (p. 451).
Giovanni Berchet, Idee del sig. Sismondi sul Poema di Dante (7 gennaio 1819), in Il Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, a cura di V. Branca, Firenze, Le Monnier, 1948-1954, vol. II, pp. 23-27. Contro un dantismo di maniera, Berchet si apre alla critica d oltralpe, quella del Sismondi in particolare, dal quale recupera l idea della Commedia in funzione dei propositi romantici come massima espressione di letteratura popolare : Venne Dante. Pose mente a tutta la suppellettile poetica lasciatagli da trovatori e dai trovieri ed alla popolarit loro. Pose mente alle poesie de siciliani ed alla popolarit della loro lingua e de loro metri. Pose mente allo spirito religioso, meditativo, teologico, scolastico del suo secolo, ed alla popolarit di tutti gli argomenti desunti dalla fede. Vide che nessuno de poeti moderni, che lo avevano preceduto, s era giovato abbastanza dell arte onde scuotere fortemente le anime, e che nessun filosofo era penetrato nei recessi del pensiero e del sentimento. L argomento [ ] Era inoltre collegato pi strettamente di qualunque altro con tutte le passioni politiche de tempi, con tutte le memorie di patria, di gloria, di fazioni civili, di virt e di delitti magnanimi, perocch tutti i morti illustri dovevano ricomparire innanzi a viventi su questo nuovo teatro aperto dal poeta. E finalmente per la sua immensit fu il pi nobile e pi sublime argomento che mai venisse immaginato dal concetto umano . (orientamento patriottico)
Giovan Battista De Cristoforis, rec. Sulla poesia. Sermone di Giovanni Torti (20 settembre 1818), in Il Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, cit., vol. I, pp. 100-105. Parmi vederne chiara la ragione in ci che non si studiano gli antichi come fece Dante con Virgilio, e Virgilio con Omero; ma si vogliono seguire quei modelli con cieca e pedantesca servilit , e si ama di evitare il peso di una fatica, che riesce infinitamente minore adottando pensieri gi detti e ripetuti in mille volumi, anzich procurando di creare il bello con novit di pensieri e con filosofia. Dal che viene sempre a cagionarsi un altra molto disdicevole deformit , quella sciocca mistura cio di antico e di recente, di idolatria e di cattolicismo, di falso e di vero che gli scrittori viventi, educati secondo i principj e le passioni dominanti nel secolo e nel paese loro, non possono a meno di non produrre naturalmente, quando fanno violenza al buon senso per dare ad argomenti moderni vestimenti foggiati alla greca od alla romana. E non di tempra siffatta al certo sono gli esempj, che del perfetto comporre diede l Alighieri nella sua divina commedia .
Pietro Borsieri, Sullo spirito profetico de poeti (27 settembre 1818), in Il Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, cit., vol. I, pp. 138-141. Un poeta, primo emulatore e non imitatore degli antichi, il divino Dante, sembr vaticinare ancor esso gli aspetti del cielo, che sarebbersi presentati ai navigatori nel tentare le strade conducenti al nuovo mondo. Sono noti quei versi del 1 del Purgatorio [Purgatorio, I, vv. 22-27]: I mi volsi a man destra, e puosi mente A l altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai fuor ch a la prima gente. Goder pareva l ciel di lor fiammelle. Oh settentrional vedovo sito, Poi che privato se di mirar quelle! Quattro stelle di singolare bellezza vennero in fatti vedute verso il polo antartico al concittadino di Dante Amerigo Vespucci, il quale scrive che veleggiando pel nuovo mondo si sovvenne dei mirabili versi del poeta, e fece risuonare della loro ignota armonia le vaste solitudini di quei mari . Ruolo dei poeti nella fondazione della civilt
Carlo Giuseppe Londonio, Appendice ai Cenni critici sulla poesia romantica (1818), in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., vol. I, pp. 319-320. Nel contestare il nuovo sistema di educazione poetica avanzato dal di Breme, incasella la pratica estetica entro le fisse ripartizioni della retorica (inventio, dispositio, elocutio, memoria e actio): di fatto lo scrittore, sebbene nel momento dell inventio fosse affrancato dai vincoli normativi, per dare cos spazio in linea con quanto gi sostenuto dai teorici sensisti alla propria libert espressivo-emotiva, nel momento della dispositio e dell elocutio doveva comunque attenersi ai rigidi parametri stilistici di stampo classicistico. Insiste sul momento della fredda e posata riflessione cui ogni poeta deve costantemente sottoporre l intemperante effervescenza della propria immaginazione . A sostegno della sua tesi, il Londonio riporta le note terzine che Dante rivolge a Virgilio [Inferno, I, vv. 82-87]: O degli altri poeti onore e lume, Vagliami il lungo studio e l grande amore Che m ha fatto cercar lo tuo volume. Tu se lo mio maestro e l mio autore; Tu se solo colui da cu io tolsi Lo bello stilo che m ha fatto onore. Reinterpreta le terzine come una vera e propria dichiarazione di poetica, in cui viene attribuito il merito dell elevatezza dei propri versi non alla spontanea virt dell estro, bens al lungo studio dei testi del suo maestro.
Carlo Giuseppe Londonio, Appendice ai Cenni critici sulla poesia romantica (1818), in Discussioni e polemiche classico-romantiche, cit., vol. I, pp. 319-320. Ora che direbbe il Dante, quel Dante del cui nome pur vorrebbero i novelli riformatori del buon gusto illustrare i propri vessilli, che direbbe egli sentendosi associato a gente che, nell irritazione del modesto suo amor proprio, tratta da pedanti Orazio, Aristotele, Quintiliano, e non riconosce altra norma che la propria fantasia?
Ermes Visconti, Analisi delle nozioni annesse in letteratura al vocabolo stile, in Id., Saggi sul bello sulla poesia e sullo stile, a cura di A.M. Mutterle, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 307-308. Sarebbe interessante contrapporre alla riflessione londoniana dei versi danteschi quelli addotti a modello esemplificativo da Ermes Visconti. Questi intende ricondurre non soltanto il momento della pura invenzione, ma anche quello della collocazione e della scelta dei termini da impiegare nella costruzione poetica all immediatezzadell atto immaginativo: Pensare una cosa immediatamente dicibile e proferire il termine, sono due operazioni intimamente connesse, e da non segregarsi l unadall altra. [ ] Chi non vi ha riflettuto creder forse che si debba necessariamente pensare prima alle nozioni, poi ai segni. Che Dante, per esempio, prima di scrivere il verso: E come albero in nave si lev [Inf., XXXI, 145] descrivente Anteo gigante che sorge nella sua colossale statura dopo essersi chinato a posare i due poeti nell infima bolgia abbia dovuto concepire separatamente le nozioni albero e nave, per trovare i due sostantivi; che abbia dovuto figurarsi l azione di levarsi prima di delinearla con un verbo. Ma se vorremo trarre induzione da quello che accade a noi stessi quando parliamo, non tarderemo a restar persuasi: che Dante prima di tutto avr ideato il totale della immagine; che venendo in seguito a tratteggiarla, le idee spieganti albero, nave ecc. si saranno presentate a lui a dirittura coi loro segni e mediante i loro segni, che anzi qualcuno di essi sar stato gi dinanzi alla memoria fin da quando egli era occupato dall insieme del concetto fantastico . [Non si tratta di operazioni studiate e meditate, rivenienti dai manuali di retorica, ma di un intervento diretto, intima espressione della creativit dell autore].
Ludovico di Breme, Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca (6 maggio 1819), in Il Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, cit., vol. II, pp. 537-546. Dante (e con lui Petrarca) rappresentato come il genio indomito, germogliato nello squallore di un secolo barbaro: Dante e Petrarca [ ] furono uomini d ingegno e di gentilezza cos trascendenti oltre la portata di quella ignara, superstiziosa, rozza e maligna et , che, spenti essi, n civili costumi, n luminosi esemplari, n pubblici istituti furono da tanto di mantenere gl ingegniall altezza di quella loro lingua, e da proseguire l educazione delle menti e dei cuori sul tenore di quei prematuri avviamenti. Cessato il felice influsso di Dante e di Petrarca, sottentr di bel nuovo quello della ignoranza e della barbarie .
Silvio Pellico, Gertrude of Wyoming. Poema in tre canti di Tomaso Campbell (14 gennaio 1819), in Il Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, cit., vol. II, pp. 49- 58. Anche Pellico tiene a ribattere alle accuse dei detrattori che chiamano barbari Shakespeare, Schiller, Goethe e tutti gli scrittori che, come Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, hanno una straordinaria impronta d originalit , giungendo a una definizione del ruolo etico-civile della letteratura: I romantici d Italia [ ] pensano come gi pensarono l Allighieri, il Petrarca, il Tasso e l Ariosto, che dai greci e latini si debbano non copiare eternamente gli stessi quadri, ma bens imparare a dipingere nuovi quadri colla stessa arditezza di disegno e armonia di colorito. Essi dicono che la letteratura la pi inutile delle arti se non ha per iscopo di scaldare il cuore della nazione in cui viene coltivata, ispirando un vivo entusiasmo non gi per la sola musica di un bel verseggiare o periodare, ma ben pi per le idee generose, pei sentimenti elevati, per tutte le virt che possono nobilitare un popolo agli occhi del mondo e di se medesimo .
Silvio Pellico: I. Francesca da Rimini (fortunata opera teatrale, rappresentata con successo al Teatro Re di Milano nell agosto del 1815 e pubblicata nel 1818): rivisitazione in chiave politica e patriottica. Si veda, ad esempio, il monologo di Paolo sull Italia nell Atto I (vv. 222-239): Stanco Son d ogni vana ombra di gloria. Ho sparso; Di Bizanzio pel trono il sangue mio, Debellando citt ch io non odiava, [...] Per te, per te che cittadini hai prodi, Italia mia, combatter se oltraggio Ti mover la invidia. E il pi gentile Terren non sei di quanti scalda il sole? D ogni bell arte non sei madre, o Italia? Polve d eroi non la polve tua? Agli avi miei tu valor desti e seggio, E tutto quanto ho di pi caro alberghi!
II. La morte di Dante (una delle undici novelle in versi raccolte nel 1837 nelle Poesie inedite): immaginata l ora estrema di Dante che perdona i propri nemici e la lontana patria crudel che gli fu noverca . tracciato un ritratto del poeta non convenzionale, facendone un alfiere della concordia nazionale guidato dall autenticit dei valori cristiani (vv. 78-90; 155-158; 237-252). Dite a Fiorenza, e in un con essa a quante Son dell amata Italia mia le spiagge, Che s io censor severo e fremebondo Ne miei carmi di foco ira esalai, Men da rabbia dettati eran que carmi Che da des o perenne e tormentoso Di ritrarre e caduti e vacillanti D infra il sozzume lor di melma e sangue. E se nell ira mia sfolgor vampa D orgoglio e d odio, or ne pensier di morte La condanno e l estinguo, e prego pace A miei nemici s viventi ancora, 90S nella notte dell avel sepolti. Ripigliando sclam : Quanto sei bella Fiorenza mia! Quanto sei bella, o Italia, In tutte le tue valli, ancorch sparse D ossa infelici e di crudeli istorie! [ ] - Giovine insano! Disse con voce moribonda il vate: Deh, sii miglior di me! Mia forza im ta, Non l ire mie superbe. - O padre Dante, Ripigli quegli, se i miei d non ponno Invece de tuoi d farsi olocausto, Consiglia, impera; dimmi: ov la insegna Nel secol mio pi santa? ov la insegna Cui dar palma Iddio sovra gl iniqui? Ov la insegna destinata a cose Sulla terra sublimi? Io vo seguirla! E il vate a lui: - Non chieder tanto: il ferro E la mente consacra al natio prence, Al natio lido, e lascia a Dio l arcana Delle sorti bilancia: ogni stendardo Che non sia traditor guida a virtude.
Alessandro Manzoni - 1801 Del trionfo della Libert (poemetto in quattro canti); Dante redivivo e Dante ingentilito , filtrato per attraverso la visione del Monti, il quale viene addirittura anteposto allo stesso Dante: Tu il gran cantor di Beatrice aggiungi, / E avanzi, talor . 1809 poemetto Urania: Dante presentato come restauratore dell itala Poesia , alla quale fu de l ira maestro e del sorriso . 1873 Dell indipendenzad Italia: [Tommaseo: Manzoni stato severo nei confronti di Dante] in merito all Italia trecentesca, Manzoni giudica un sogno l idea imperiale dantesca ( tristo stato di cose, in cui anche un alta mente non aveva altra alternativa che o di disperare, o di sognare ) e rifiuta il luogo comune che intende Dante profeta dell unit italiana. Se il sogno della restaurazione dell impero si fosse realizzato, l unit italiana non avrebbe avuto luogo. Il primato di Dante deve intendersi non in termini politici, ma letterari. - - PS: Nel 1863 una Commissione chiese a Manzoni la firma per una petizione al Parlamento volta a dichiarare festa nazionale il giorno della nascita di Dante. Manzoni obiett che la storia non aveva dato ragione a Dante; anzi, gli Italiani, invece di seguire le idee di Dante, avevano dato voce al proprio buon senso (all Italia unita nella soggezione all Imperatore tedesco avevano preferito quella retta da leggi proprie). Lasciando dunque alle disputazioni se Dante abbia dato origine a un Italia civile e politica; ma niuno certamente contraddir che Dante ha creato un Italia intellettuale; in ci la sua gloria d esser padre della patria io la credo incontestabile .
Giuseppe Mazzini - 1827: invi alla rivista fiorentina, l Antologia , il suo primo scritto, l articoloDell amor patrio di Dante [rimasto inedito e pubblicato solo nel 1837 su Il Subalpino ]. Secondo la lezione storicistica della critica romantica, adotta come canone ermeneutico nel confronti dell opera di Dante lo studio congiunto del dato storico e di quello biografico: A voler giudicare dirittamente delle ragioni di un opera, dei motivi, che la dettarono, dei sentimenti sotto la inspirazione de quali fu scritta, e quindi della sua interpretazione, parmi affacciarsi un unica via, tropo spesso negletta; lo studio de tempi, in cui fu composta, e quello della vita dello scrittore . - Legge in controluce, nella poesia di Dante, trasparenti analogie con la situazione dell Italia restaurata, vittima, come nell et comunale, dei campanilismi e della strategia imperialistica delle grandi potenze. - Reagiva all accusa rivolta a Dante d intollerante e ostinata fierezza, e d ira eccessiva contro Firenze. In un popolo guasto reso violento dalle contese domestiche ed estere e la cui fantasia poteva essere scossa soltanto dalla rappresentazione di dannati e di eterni tormenti sar santo l ufficio della satira: non lo stile grave di Persio , n la delicata ironia di Parini , ma le parole di sdegno, di fuoco, d iracondo dolore. Tuttavia, lo sdegno e il risentimento che spirano le invettive dantesche non sono mai scoppio di furore irragionevole o d offeso orgoglio : nei versi che pi infieriscono tu senti un pianto che gronda sulla dura necessit , che i fati della patria gl impongono . -